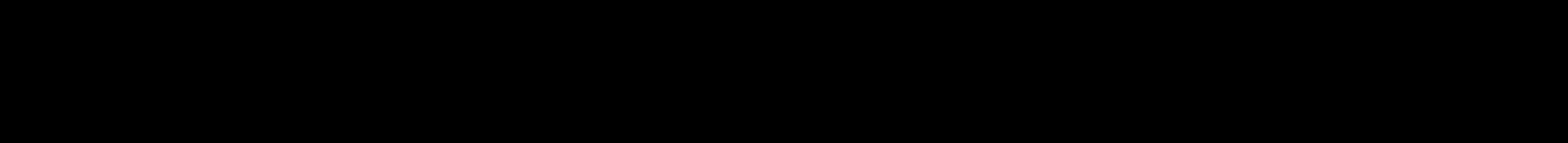
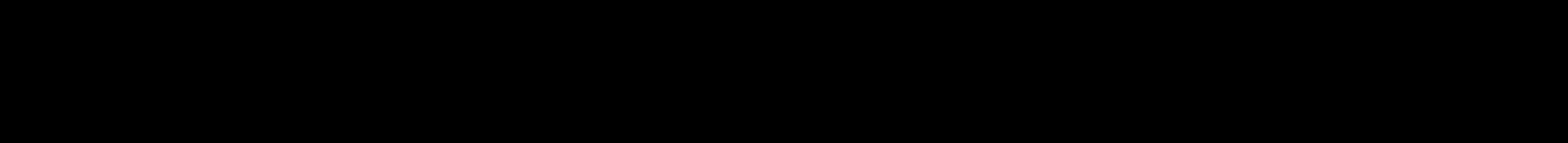
di Giulio Ghirelli
 Volare oh oh, cantare oh oh oh, nel blu dipinto di blu…
Volare oh oh, cantare oh oh oh, nel blu dipinto di blu…
Era il 1958, e un poco conosciuto cantante era apparso sul palcoscenico del Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, e aveva mandato al settimo cielo -giusto in tema con la canzone- gli spettatori con il brano Nel blu dipinto di blu -più noto col nome di Volare, e ancora oggi suonato e cantato in tutto il mondo- vincendo l’ottavo Festival della Canzone Italiana. Il cantante: Domenico Modugno.
Dal quarto piano della nostra casa di ringhiera, mentre stendeva le lenzuola sopra il cortile, la mia mamma, con la sua squillante voce, diffondeva in tutto il caseggiato le parole di quella canzone.
Sono nato a Milano in via Bodio, al quartiere Bovisa, ma quando avevo un anno i miei genitori si spostarono in una casa di ringhiera di via Piero della Francesca, al Borgo degli ortolani, che i vecchi del quartiere chiamavano: Riòn dei scigollàt (Rione dei cipollai).
 L’origine del Borgo degli ortolani risale ad alcuni secoli fa, e si sviluppava lungo la via Luigi Canonica ed il suo naturale proseguimento, cioè la via Piero della Francesca.
L’origine del Borgo degli ortolani risale ad alcuni secoli fa, e si sviluppava lungo la via Luigi Canonica ed il suo naturale proseguimento, cioè la via Piero della Francesca.
Anticamente, le risorse idriche della zona -il Nirone insieme a varie rogge e fontanili- furono uno dei motivi principali per cui vennero costruite una serie di cascine lungo la strada postale per Varese -cioè la via Canonica- i cui prodotti, frutta, ortaggi e verdure, venivano coltivati e venduti in abbondanza, dando così origine al nome del borgo.
Dalla mia casa di ringhiera, sin dalle prime ore del pomeriggio usciva una marea di ragazzini che, suddivisi a seconda dell’età, si riunivano in squadre che invadevano le vie circostanti.
E’ difficile immaginare che le strade della metropoli, oggi invase da un caotico traffico di veicoli, sessant‘anni fa fossero un luogo di ricreazione per i bambini.
Era un gran viavai di fanciulli che sfrecciavano su monopattini o pattini a rotelle, e i più grandi e fortunati con le biciclette, che allora erano il regalo più ambito di tutti i ragazzini.
I giardinetti di via Poliziano, che oggi si sono trasformati in parcheggi per auto, ospitavano una chiassosa moltitudine di marmocchi impegnati a giocare al pallone o in quei giochi di cui oggi non si conosce nemmeno più il nome.
Anche allora i passanti dovevano far gincane, però non tra auto e moto come oggi, ma tra gruppi di bambini che giocavano. Le bimbe più piccole facevano il girotondo cantando: Oh quante belle figlie Madama Dorè, oh quante belle figlie…. mentre i maschietti si scavalcavano a turno al gioco della cavallina, recitando: Uno, monta la luna, due, monta il bue, tre, la figlia del re…
 Sui marciapiedi si tracciavano -con scaglie di mattone che venivano usate come gessetti- piste da far percorrere ai tollini (i tappi a corona delle bibite) che venivano lanciati con la punta delle dita.
Sui marciapiedi si tracciavano -con scaglie di mattone che venivano usate come gessetti- piste da far percorrere ai tollini (i tappi a corona delle bibite) che venivano lanciati con la punta delle dita.
Lo chiamavamo Giro d’Italia, perché il sogno di noi bambini era di diventare campioni di ciclismo.
I più grandi, se non avevano la fortuna di disporre di una palla, giocavano alla lippa, mentre i tiratori scelti si davano battaglia con le cerebottane (dei tubetti di metallo da cui si soffiavano dei proiettili di carta contro l’avversario).
Quelli veloci di gambe si rincorrevano nel gioco del tighelett o in quello di bandiera.
C’erano poi quelli che scavavano, nella terra dei giardinetti, delle contorte piste per fare le gare con le biglie, mentre i più intellettuali confrontavano tra loro le figurine Liebig, contrattando gli scambi di quelle doppie come abili mercanti. Rarissima la figurina del Feroce Saladino.
Madama Dorè, tighelett, lippa: nomi arcaici -qualcuno dialettale- di giochi obsoleti. Nomi che è impossibile coniugare con gli attuali Game boy, Play station, I pad…
Obsoleto anche il nomignolo che gli adulti davano ai discoli come me: Giamburrasca.
Mi chiamava così la sciura Colomba, la portinaia del nostro caseggiato; e a dirla giusta, io con lei non ero un discolo, ma una peste! Era uno dei miei bersagli preferiti, e quando passavo davanti alla portineria e la vedevo con le sue braccine a mezz’aria come un pinguino, mimavo con le braccia il movimento delle ali e le cantavo il ritornello di un brano di qualche anno prima, cantato da Nilla Pizzi: Vooola, colomba bianca vooola…
La sciura Colomba diventava ancor più paonazza in viso e balzava fuori dalla guardiola, ma poiché era piccola e grassa non riusciva a rincorrermi sugli ottantatre gradini che mi portavano a casa, e allora si armava dello scopino per pulire i soffitti -dal manico lungo circa tre metri- e lo infilava tra le ringhiere delle scale per cercare di farmi lo sgambetto, strillando: “Giamburrasca, brütt malnàt, se te ciapi!…” (brutto birbante, se ti prendo!…).
Ma il mio secondo nomignolo Gamba de sèler (Gamba di sedano) non mi era stato dato a caso; con le mie lunghe e magre gambe, nel tempo che la sciura Colomba infilava il lungo scopino nella prima rampa di scale, io ero già al secondo piano. Naturalmente per il resto della giornata era rischioso passare davanti alla portineria; dovevo avvicinarmi cautamente alla guardiola, vedere se la Colomba fosse a debita distanza e attraversare l’androne come un razzo; ma siccome ero una vera peste, dopo aver oltrepassato la guardiola, chiamavo a gran voce la portinaia, e appena lei si affacciava, io riattaccavo la solfa: Vooola, colomba bianca vooola…
E alla povera portinaia non restava che sfogarsi con mia madre, la quale, quando alla sera rientravo dalle mie scorribande, mi dava la paghetta: uno scappellotto sul coppino, che arrivava a tradimento nel momento in cui non riuscivo a svignarmela, cioè quando ero seduto a tavola a gustarmi la zuppa di pane e caffelatte.
Ma la sciura Colomba aveva un cuore di marzapane, e il giorno dopo mi voleva bene come prima.
Suo marito faceva il bigliettaio sul tram (a quei tempi il biglietto si comprava sul tram) ed era copia conforme della moglie: piccolo, tondo e rubizzo. Quando si dice: chi si somiglia si piglia…
Dal rubicondo colore delle loro facce, non ci si meravigliava nel vedere un attestato con medaglia d’oro dell’Avis -Associazione Donatori Sangue- incorniciato in bella vista nella guardiola della portineria. Anche i loro due figli -un maschio e una femmina- erano di uguale conformazione, e vedere quella famiglia attraverso la finestra della guardiola mentre erano seduti attorno al tavolo a pranzare, era come vedere un quadro di Botero.
Ma la sciura Colomba non era l’unica mia distrazione in quella casa.
C’era la Wilma, una ragazzina di tredici anni, figlia di un capo ufficio dell’Alfa Romeo, che abitava al terzo piano della facciata di fronte alla mia, che era l’ala elegante del fabbricato -senza ringhiera e con ingresso dalle scale-. La posizione della sua abitazione, che aveva tutte le finestre rivolte verso il mio pianerottolo, mi faceva vedere la Wilma nelle varie fasi della giornata: la vedevo quando mangiava in cucina, e quando faceva i compiti nella sua cameretta; la spiavo quando andava in bagno a spazzolarsi i boccoli castani, dato che lei aveva il lusso di avere il bagno nell’appartamento, a differenza di noi proletari che avevamo il gabinetto alla turca sul pianerottolo, e in comune con gli altri inquilini del piano. E tenevo d’occhio la ragazzina quando andava a giocare sul pianerottolo della Carluccia, una fanciulla magra magra che sembrava uno scheletrino.
La Carluccia abitava al primo piano del lato proletario con le ringhiere. Sua mamma faceva la sarta e avanzava tanti ritagli di stoffa, e con quei rimasugli la Carluccia e la Wilma giocavano a fare le sarte. Si mettevano sul pianerottolo davanti a casa della Carluccia con forbici e aghi, e facevano i vestiti per le bambole; anche se ormai l’età delle bambole l’avevano superata, e i loro interessi cominciavano a farsi più sbarazzini…
E siccome anch’io non ero più in età da orsacchiotti, i boccoli castani e le cicciottelle fattezze della Wilma mi facevano un effetto fino ad allora sconosciuto. Ma quell’argomento non era di primario interesse, perché innanzitutto venivano i miei compagni che avevano la bicicletta.
Dopo gli antichi tempi del triciclo, tornavo ad essere entusiasticamente con i piedi sui pedali.
 Per la mia promozione in terza media, il papà mi aveva regalato la bicicletta, e con quel dono mi si era aperto un mondo nuovo.
Per la mia promozione in terza media, il papà mi aveva regalato la bicicletta, e con quel dono mi si era aperto un mondo nuovo.
A quei tempi la bicicletta era un lusso, un bene prezioso che non tutti i ragazzini avevano la fortuna di possedere; e pure per gli adulti era un mezzo di trasporto pregiato. E preso di mira dai gratta.
Perciò non si lasciava la bicicletta in strada legata a un palo, perché i ladri di biciclette erano una categoria molto diffusa e con l’occhio lungo, ma la si carivava in spalla e si facevano anche quattro o cinque piani a piedi per ricoverarla in casa. E se l’abitazione era troppo piccola, la si collocava sul pianerottolo davanti alla porta di casa.
Qualcuno si ricorderà il bellissimo film del 1948 Ladri di biciclette, che procurò a Vittorio de Sica un premio Oscar, sei Nastri d’Argento e molti altri riconoscimenti.
Quattro anni dopo la sua uscita, venne ritenuto dalla rivista cinematografica inglese Sight & Sound il più grande film di tutti i tempi. Ed è stato in seguito classificato dalla rivista Empire nella quarta posizione ne “I cento migliori film del cinema mondiale – I più grandi film non in lingua inglese”.
Questo drammatico film mostra significativamente quanto questo mezzo a due ruote fosse prezioso.
Narra le vicissitudini di Antonio Ricci, nella Roma del secondo dopoguerra, che trova lavoro come attacchino comunale. Per lavorare deve però possedere una bicicletta, e la sua è impegnata al Monte di Pietà, per cui la moglie Maria è costretta a dare in pegno le lenzuola per riscattarla.
Ma proprio il primo giorno di lavoro, mentre è impegnato a incollare un manifesto cinematografico, la bicicletta gli viene rubata. Antonio insegue il ladro ma inutilmente. Allora, facendosi aiutare dal figlioletto Bruno, va alla ricerca del maltolto. Si reca prima a Piazza Vittorio e poi a Porta Portese, dove solitamente vengono rivenduti gli oggetti rubati, ma non la trova. Però proprio a Porta Portese, Antonio rivede il ladro, che riesce a dileguarsi tra la folla. Solo per caso Antonio si imbatte di nuovo nel ladro in un rione malfamato, dove però tutti gli abitanti prendono fermamente le difese del ladro, minacciando il derubato. E neppure l’intervento di un carabiniere, che non trova prove concrete, può fare alcunché per arrestare il malandrino. Stravolto dalla stanchezza e scoraggiato, Antonio attende insieme a Bruno il tram per tornare a casa, quando nota una bicicletta incustodita.
Preso dalla disperazione, tenta maldestramente di rubarla, ma viene subito fermato e aggredito dai passanti. Solo il pianto disperato del figlio, che muove a pietà i presenti, gli evita di essere fermato e denunciato. La scena finale mostra Antonio e Bruno allontanarsi avviliti tenendosi per mano.
 A Milano, un luogo per procacciarsi una bicicletta rubata era la Fiera di Sinigaglia, il più vecchio mercato cittadino delle pulci. Capitava che i derubati ritrovassero il loro velocipede in bella mostra tra i banchi della fiera; e poteva succedere che ci fossero scazzottate tra il venditore e il depredato.
A Milano, un luogo per procacciarsi una bicicletta rubata era la Fiera di Sinigaglia, il più vecchio mercato cittadino delle pulci. Capitava che i derubati ritrovassero il loro velocipede in bella mostra tra i banchi della fiera; e poteva succedere che ci fossero scazzottate tra il venditore e il depredato.
Era un’usanza della gente meno abbiente, quella di procurarsi una bicicletta al mercato delle pulci, poiché si spendeva la metà della metà rispetto al costo di quella nuova.
Mio papà, che aveva una modesta paga da carabiniere, non poteva comprarmi una bicicletta nuova, ma mai sarebbe andato a comprarne una alla Fiera di Sinigaglia, col rischio che fosse una di quelle rubate. Quindi si recò nella bottega di un biciclettaio e me ne comprò una usata.
Il giorno che rientrai a casa ed ebbi la sorpresa di vedere sul pianerottolo una bicicletta appoggiata alla ringhiera davanti alla porta di casa, mi venne un tuffo al cuore. Certo avrei preferito una bici sportiva col cambio, e magari di un bel colore azzurro come le “Bianchi”.
E quella nera “Dei” di foggia classica e coi freni a bacchetta, che per mio papà era il massimo della sobrietà, non mi fece fare salti di gioia.
Ma non si può aver tutto dalla vita, e comunque avevo un velocipede che mi permetteva di unirmi ai miei amici ciclisti, dandomi la possibilità di raggiungere mete fino ad allora impossibili.
E questo era un fatto che mi dava la certezza di potere scoprire il mondo intero.
Non ero più il ragazzino che passava i pomeriggi sui giardinetti di via Poliziano, alle prese con le biglie o la lippa; adesso facevo parte della squadra dei giovani audaci, che sulle due ruote uscivano dal quartiere e si avventuravano oltre i confini della città.
Fra le nostre mete preferite c’erano le rogge, quei piccoli corsi d’acqua che si diramano fra i campi per irrigare le coltivazioni. Ne avevamo scoperta una a Trenno, sulla via Novara, dove, oltre a fare il bagno, facevamo spuntini con le carote che rubavamo nei campi degli ortolani.
 Oppure attraversavamo la città e andavamo a fare il bagno all’Idroscalo, quello specchio di acqua che veniva chiamato: il mare dei milanesi.
Oppure attraversavamo la città e andavamo a fare il bagno all’Idroscalo, quello specchio di acqua che veniva chiamato: il mare dei milanesi.
L’Idroscalo è un grande bacino artificiale alimentato da acque sorgive, che venne costruito nel 1930 come scalo per gli idrovolanti. Nel dopoguerra, nella stagione estiva le sue sponde si affollavano di cittadini milanesi, e dell’hinterland, che non potevano permettersi di andare ai laghi o al mare.
Però bisognava essere molto accorti a fare il bagno in quelle acque, poiché le sorgenti sotterranee formavano dei gorghi che risucchiavano verso il fondo, e più di una volta avevamo visto arrivare la barca di soccorso per salvare un bagnante. E se poi arrivava il motoscafo dei pompieri, era per recuperare un annegato. Ma l’incoscienza della nostra età non ci dissuadeva e arrivavamo fin lì con le nostre bici, ci spogliavamo fino a restare in mutande e ci tuffavamo in quell’acqua infida.
Uno di quei giorni d’estate, il Beppe -figlio del vinaio che aveva l’osteria sotto casa- che era l’unico a possedere una bici da corsa, una Bianchi azzurra con cambio e borraccia, ci propose di fare una pedalata fino al lago di Segrino, in quel di Canzo, sopra Erba.
Salvo lui, nessuno aveva idea dove si trovasse e quanto fosse distante quel posto -una sessantina di chilometri e con l’ultimo tratto con una salita bella tosta-.
Ma a nessuno di noi venne la curiosità di chiedere lumi al Beppe; a quell’età chi non ha lo spirito avventuroso? Per non dire incosciente…
Il Beppe si raccomandò di non parlarne ai nostri genitori, perché se avessero saputo che sfidavamo i pericoli delle strade extraurbane, sicuramente non ci avrebbero lasciato andare.
Il gruppo ciclistico era composto, oltre che dal Beppe, dal Marco Motta detto Mamo, figlio del fornaio, dal Silvano Moroni detto Moni, figlio della portinaia, e dal sottoscritto.
Il mattino della partenza riempimmo quattro bottiglie con acqua corretta di qualche goccia di aceto, perché il Beppe diceva che era un’ottima miscela dissetante; e se lo diceva un competente come lui, che aveva la bici da corsa…
Come viveri avevamo messo in una sacca di tela da portare a tracolla: otto panini, quattro scatolette di carne Simmenthal, le bottiglie dell’acqua e un’anguria bella grossa.
Arrivare al lago di Segrino non fu come dirlo; già tutti quei chilometri per arrivare a Erba non furono una passeggiata, ma la salita che da lì portava a Canzo fu veramente una mazzata.
In più c’era la zavorra della pesante sacca che portavamo a turno, escluso il Beppe, che come capo-gruppo con tanto di bici professionale, non voleva saperne di fare il facchino.
Lui, con la leggera bici da corsa col cambio, faceva il baldanzoso sulle salite del Segrino, ma noi, che avevamo pesanti biciclette proletarie, arrancavamo con la lingua penzoloni come cani sfiatati.
In più, io e il Mamo dovevamo prenderci cura del Moni, che siccome era una palla di lardo di una novantina di chili, su quelle salite gli era venuta la faccia paonazza che pareva che scoppiasse.
E mentre il Beppe era già coi piedi a bagnomaria nel laghetto, noi stavamo ancora arrancando sulle salite, le ultime delle quali ci toccò farle a piedi, spingendo la palla di lardo e la sua bici.
Ma dopo una mezz’oretta, verso la una, arrivammo anche noi alla meta.
Il lago di Segrino è fatto di acqua sorgiva talmente fredda, che farci il bagno si rischia la polmonite, e quindi potemmo solo pucciare i piedi e lavarci il sudore della faccia. Però le scatolette di carne e l’anguria, messe in fresco dentro l’acqua, furono un bel toccasana alle nostre fatiche.
Il pomeriggio, vuoi per la stanchezza, vuoi perché avevamo la pancia bella piena di anguria e carne Simmenthal, lo passammo pigramente sdraiati in riva al lago, senza alcuna voglia di rimetterci in sella, ignorando le sollecitazioni del Beppe che diceva che si faceva tardi.
Solo quando lo vedemmo partire a cavallo della sua bici, ci mettemmo in viaggio pure noi.
Fino dopo Erba andò che era una meraviglia: tutto in discesa! Ma i rimanenti cinquanta chilometri furono un patimento unico. Le mie gambe sembravano di gesso e non riuscivano a spingere sui pedali. La faccia del Moni era ormai violacea, ed era più il tempo che si fermava a prender fiato che quello che pedalava.
Arrivammo a casa che erano quasi le nove di sera, e le facce dei nostri genitori, che stazionavano allarmati sul portone di casa, non dicevano niente di buono.
Non vidi cosa gli toccò ai miei compagni d’avventura, perché ero troppo impegnato a schivare gli scappellotti di mia madre, intanto che mi facevo gli ottantatre gradini con la bici in spalla. La quale finì sottochiave in solaio. E per parecchi giorni mi ritrovai sui giardinetti di via Poliziano a giocare a biglie e alla lippa con i marmocchi.
Ma quell’avventuroso raid ciclistico diventò un argomento molto gettonato su quei giardinetti, e i compagni di gioco mi guardavano con rispetto e ammirazione.
Quando la mamma mi restituì la bicicletta, il Moni non si unì più al nostro gruppo; faceva i suoi giretti in bici intorno a casa, perché suo padre lo aveva confinato entro quei limiti.
Quando andavamo a fare le gite in bicicletta a Trenno, sentivamo la sua mancanza; al nostro gruppo ciclistico era venuto a mancare il pezzo da novanta!
Erano i tempi in cui i Milanesi, dagli adulti ai più piccoli, aspettavano per ore lungo i giardinetti di corso Sempione per vedere passare il Giro d’Italia, con in testa i grandi campioni di allora: Fausto Coppi e Gino Bartali.
 E alla radio il Trio Lescano cantava ancora: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?…
E alla radio il Trio Lescano cantava ancora: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?…
Altri racconti di Giulio Ghirelli
Racconti & Ricordi*anzianiincasa.it