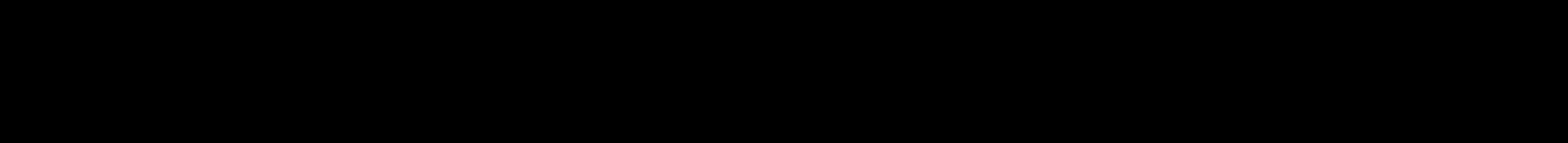
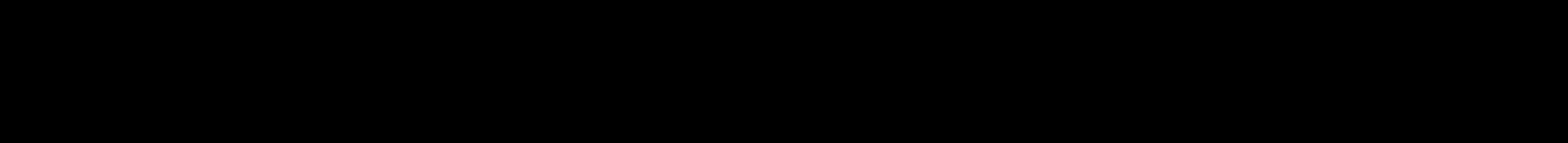
di Giulio Ghirelli
Correva l’anno 1967 e la TV era in bianco e nero. Confesso di essere innamorato del bianco e nero.
Ho imparato ad amarlo quando ero giovanissimo e squattrinato, e per risparmiare mi ero costruito un piccolo laboratorio fotografico nel bagno, per stamparmi da solo le foto. Inizialmente la scelta fu obbligata: bianco e nero, perché la pellicola e la carta per la stampa a colori costavano molto di più.
E siccome, come recita quel detto: La necessità è la madre delle abilità, imparai a stampare bene il bianco e nero, e quindi ad amare quel genere di fotografia, che è più impegnativa rispetto a quella a colori, perché trasformare in bianco e nero ciò che il nostro occhio vede a colori, non è così semplice. Vedi un bel paesaggio, il mare blu, il cielo azzurro, il prato verde… scatti la foto, e quando la stampi può capitare che ti trovi tra le mani una scialba immagine. Perché il mare che è diventato grigio medio, il cielo grigio chiaro e il prato grigio scuro, non sempre hanno l’effetto che desideravi. Così dicasi per la pellicola a colori, che può capitare che non restituisca l’effetto della scena immortalata.
Nella foto, scattata nel 1985 a St.Malo, intitolata Si fa sera -e credo sia inutile spiegare il motivo di questo titolo- non riesco a immaginare come avrei  potuto -con la pellicola a colori- ottenere questo suggestivo effetto, accentuato dalle nuvole che sembrano essere in quella scena per proteggerne l’intimità. E qui, per chi non lo sapesse, rivelerò un trucco. Uno dei pochi che la pellicola in bianco e nero concedeva. Cioè i filtri -dei vetrini colorati che si mettevano davanti all’obbiettivo, che a seconda dei colori, accentuavano certi particolari della scena. Per le nuvole si usava un filtro giallo per evidenziarle un poco, un po’ di più col filtro arancione, e il massimo effetto, quasi opprimente, lo si otteneva col filtro rosso-. Dopo che ho rivelato questo trucco, non credo sia necessario spiegare come sia stata importante la complicità del filtro arancione per questa immagine.
potuto -con la pellicola a colori- ottenere questo suggestivo effetto, accentuato dalle nuvole che sembrano essere in quella scena per proteggerne l’intimità. E qui, per chi non lo sapesse, rivelerò un trucco. Uno dei pochi che la pellicola in bianco e nero concedeva. Cioè i filtri -dei vetrini colorati che si mettevano davanti all’obbiettivo, che a seconda dei colori, accentuavano certi particolari della scena. Per le nuvole si usava un filtro giallo per evidenziarle un poco, un po’ di più col filtro arancione, e il massimo effetto, quasi opprimente, lo si otteneva col filtro rosso-. Dopo che ho rivelato questo trucco, non credo sia necessario spiegare come sia stata importante la complicità del filtro arancione per questa immagine.
 Questa seconda fotografia, scattata in corso Sempione a Milano, penso che sia inutile dire che solo la pellicola a colori poteva far risaltare l’arancione del tram dal resto della scena. Si può immaginare la differenza, se quel tram fosse stato grigio, quasi indistinguibile tra tutti i toni grigi dello scenario.
Questa seconda fotografia, scattata in corso Sempione a Milano, penso che sia inutile dire che solo la pellicola a colori poteva far risaltare l’arancione del tram dal resto della scena. Si può immaginare la differenza, se quel tram fosse stato grigio, quasi indistinguibile tra tutti i toni grigi dello scenario.
Quindi ho dovuto abituare l’occhio a immaginare quale sarebbe stato il risultato di una foto, prima ancora di scattarla. E tra le migliaia di scatti in bianco e nero fatti in oltre trent’anni, qualcuno mi è venuto bene, e quando vado a rivedere queste foto, ripenso con nostalgia a quelle nottate -di giorno lavoravo- trascorse nella fioca luce della lampada rossa, unica luce per l’attività in camera oscura. Chi ha vissuto quest’esperienza, saprà cosa si prova nell’immergere nella bacinella dell’acido di sviluppo il foglio fotografico bianco e vedere apparire poco a poco un’immagine, senza la certezza che sia venuta una bella foto. Ma parlo di preistoria, e non so quanti siano a ricordarsi com’è fatta una fotocamera a pellicola, in quest’epoca di fotocamere digitali talmente programmate, che fare una brutta foto è impossibile. Sto divagando, perché non è questo l’argomento di cui volevo parlare.
Dicevo che nel 1967 la TV era in bianco e nero, e chi non la possedeva ancora, andava in casa dei vicini, oppure al bar, per non perdersi una delle trasmissioni più gettonate: il Festival di Sanremo.
In quell’anno, il presentatore del festival era Mike Bongiorno, che era diventato l’idolo della TV nel 1955 con l’indimenticabile programma telequiz Lascia o Raddoppia?
Avevo undici anni, ma me lo ricordo come fosse ieri. Al giovedì sera si andava dalla vicina di casa, la sciura Esperia -una delle poche fortunate della nostra casa di ringhiera a possedere la TV- a vedere il telequiz. Ma ci toccò lasciare quell’usanza, perché la mia mamma, litigiosa come poche, era riuscita a bisticciare pure con la nostra vicina e, come si dice, fine delle trasmissioni. Che riprendemmo scendendo nell’osteria sotto casa. Ma quella bettola non era il luogo migliore per vedere la TV, dato che c’erano i giocatori di carte, ai quali non gliene importava niente del telequiz, e discutevano animatamente ogni volta che uno di loro sbagliava a giocare una carta. E siccome, come recita il detto: I conti li fa l’oste, al suddetto poco importava delle lamentele di noi telequiz-dipendenti, perché i giocatori di carte erano clienti fissi e si scolavano parecchi quartini di vino ogni sera, mentre noi, più che un caffè e un bicchiere di spuma alla settimana…
Il problema fu risolto quando le sale cinematografiche, che il giovedì sera rimanevano deserte, si attrezzarono di uno speciale proiettore collegato alla RAI, che trasmetteva in diretta sullo schermo il mitico telequiz. E che spettacolo vedere il grande Mike sul grande schermo cinematografico!
Ma torniamo al Festival del 1967. Quell’anno lo vinsero Claudio Villa e Iva Zanicchi, con la canzone Non pensare a me. Ma più che il ricordo dei vincitori, nella mia mente rimane la tragedia del suicidio del cantautore Luigi Tenco, che fece quel gesto per protesta, perché la sua canzone, eseguita in coppia con la cantante franco-italiana Dalida -pure lei suicida vent’anni dopo- era stata eliminata dalla giuria alla prima serata. Quell’anno, il rock-singer col ciuffo, l’Elvis Presley de’ noantri, cioè Little Tony, si piazzò al 10° posto con la canzone Cuore matto. Non so per quale altra analogia, se non per il fatto che avevo anch’io il cuore matto, quel pomeriggio di cinquant’anni dopo – disteso sul lettino con addosso un camicione bianco e una cuffietta in testa- mi era venuto in mente il titolo di quella canzone.
Ma voglio raccontare per bene -al presente, perché mi viene meglio- questa storia del cuore matto, e dello scherzetto che ho fatto a Tonino, il mio compagno di camera.
Venerdì, 28 Luglio 2017, ore 15 e 40 minuti.
Sono ricoverato al reparto cardiologico perché il mio cuore è diventato matto. Cioè si è messo a fibrillare esageratamente, e devo essere sottoposto a un trattamento di nome cardioversione. Il luogo dove mi faranno questo intervento non ha l’aria di un reparto clinico, ma piuttosto di una specie di deposito di lettini a rotelle, che stazionano affiancati in questa camera senza porte, in fondo al corridoio. I lettini sono vuoti, la camera è vuota… non c’è un’anima viva, salvo la mia.
Il condizionatore che mi sta congelando, e il fatto che siamo un piano sottoterra -oltre a un fifa blu-mi suscitano inquietanti presagi su questo luogo, del genere camera ardente.
Arriva un tipo in tuta e cuffietta verdina e mi appiccica due grosse piastre metalliche rotonde, una sul torace e l’altra sulla schiena. Il freddo delle piastre fa pendant con l’aria condizionata.
Poi mi infila nel braccio l’ago per l’anestesia totale; sono così teso, che manco sento bucare.
“Me lo fa lei?” chiedo speranzoso a quel tipo, un giovanotto con la faccia simpatica. Come se i giovanotti con la faccia simpatica fossero più affidabili…
“No -risponde lui- adesso arriva il medico specialista”. Me lo dice con tale cortesia, che mi sento invogliato a chiedergli: “Come funziona la faccenda?”.
“Adesso l’addormentiamo per due minuti esatti, e diamo una scossetta elettrica che ferma il cuore, che poi dovrebbe ripartire da solo in modo regolare, senza più fibrillare”.
“E se non dovrebbe ?” chiedo.
“Nella maggioranza dei casi le fibrillazioni spariscono, altrimenti bisogna intervenire con la chirurgia” risponde lui.
“No, intendo dire se il cuore non dovesse ripartire…”.
Ma una voce dal tono spocchioso non dà tempo al giovanotto di rispondermi.
La voce appartiene a un signore in camice bianco sui quarantacinque anni, capelli biondi e faccia abbronzata, tipo dandy, che arriva con aria scocciata e senza smettere di parlare con qualcuno in corridoio, in merito al prossimo week-end sul lago. “Speriamo che la Mariella non mi rompa troppo le scatole con lo sci acquatico, perché il motoscafo mica l’ho preso per trainare lei” dice il dandy, avvicinandosi al mio lettino senza degnarmi di uno sguardo, figurarsi un saluto…
Il mio tentativo di uno spiritoso approccio recitandogli il saluto dei gladiatori: Ave Caesar, morituri te salutant, cade nel vuoto. Come se non esistessi, anzi, come se non meritassi di esistere…
Il dandy armeggia qualche secondo con la macchina a cui sono attaccati i cavi dei miei elettrodi, e poi fa un cenno con la testa al giovanotto con la faccia simpatica. Il quale apre la valvola della flebo, e io sento un po’ di bruciore nel braccio. Poi non sento più niente.
Ore 15 e 42 minuti, forse.
Non so se ho riaperto gli occhi esattamente due minuti dopo, ma in queste storie quel che conta è riaprirli, e con la zucca in ordine, perché girano certe leggende sugli effetti dell’elettroshock…
Comunque riconosco il giovanotto, che ha la faccia simpatica a una spanna dalla mia, forse per capire se sono connesso. Mi osserva ancora un attimo e poi dice con aria trionfante: “Perfetto! Sessanta battiti al minuto!”. Gli sorrido mentre faccio ballare gli occhi per vedere dov’è il dandy.
Anche se mi sta antipatico, vorrei ringraziarlo. Ma non lo vedo; forse è già partito per il lago.
Il lago… L’ho lasciato tre giorni fa, e son tre giorni che mi manca. Appena mi leveranno la cuffietta e il camicione, col cavolo che resto nell’afa della metropoli! C’è la rossa che mi aspetta, intendo la moto. Appena arrivo mi ci metto a cavallo e filo dritto dal mio amico Gigi, che è ospite fisso in una casa di riposo per anziani a Gravedona.
Gliela devo proprio raccontare a Gigi, quest’avventura del cuore matto, che gli hanno dato una botta di corrente da 200 joule -una cannonata!- e lui si è fermato, e poi è ripartito da solo, regolare come un cronometro svizzero.
Il tipo simpatico mi saluta e mi lascia da solo in questa camera, che ora mi sembra meno mortuaria. Inspiro golosamente boccate d’aria condizionata, come se stessi già respirando l’aria del lago. Una mezz’oretta, e poi arriva il barellista per riportarmi al terzo piano, dove mi sta aspettando Tonino, il cardiopatico compagno di camera, col quale nell’arco di una trentina di ore ho stretto un rapporto solidale, come solo coi compagni di sventura si può stringere.
Tonino, che ha qualche anno meno di me, è in clinica per mettere tre stent nelle coronarie.
Siccome io ero attaccato alla flebo già dal giorno prima, lui mi ha accudito come un fratello, andando a prendermi le bottigliette di acqua e sparecchiandomi i piatti, senza aspettare che questi servizi li facesse l’inserviente. Un’anima bella, che quando sono venuti per portarmi giù, mi ha seguito fino all’ascensore. E io per ricambiarlo cosa gli combino?
Mentre il lettino percorre il corridoio del terzo piano, mi viene in mente Jack Nicholson in quella scena del film Qualcuno volò sul nido del cuculo, dove lui, dopo che in manicomio gli avevano fatto un elettroshock per tenerlo tranquillo, fa uno scherzo ai compagni di camerata presentandosi a loro col fare da demente, come se quel trattamento gli avesse fuso il cervello.
-La riuscita di uno scherzo, spesso sta nel tempismo tra il pensarlo e il metterlo in atto- diceva Adolfo Celi nel film Amici miei.
Infatti, con uno straordinario tempismo, a pochi metri dalla mia camera, dico al barelliere che sta spingendo il lettino: “Reggimi la parte, che adesso facciamo uno scherzetto al mio amico”.
E mentre lui mi guarda con aria ebete, io stendo le braccia sopra il lenzuolo, contraggo le dita a mò di artigli, spalanco gli occhi fin quasi fuori dalle orbite, e caccio fuori tutta la lingua, con una smorfia da fare invidia a quella di Jack Nicholson. Quindi entriamo in camera e il barelliere, tutt’altro che ebete, davanti alla faccia di Tonino, che vedendomi con quell’aspetto ha sgranato gli occhi, commenta con aria sconsolata: “L’elettroshock può fare brutti scherzi…”.
Ma per la regola che lo scherzo è bello se dura poco, e siccome la faccia di Tonino non mi dice niente di buono, smetto di fare lo scemo e alzo il pollice in segno di vittoria.
Mentre il barelliere mi aiuta a sdraiarmi sul letto, e mentre Tonino, con gli occhi lucidi e la faccia color biacca, mi osserva non sapendo se ridere o insultarmi, io penso che tra pochi giorni tornerò al lago, inforcherò la rossa e la farò rombare sulla statale Regina fino a Gravedona. Perché lo scherzetto alla Nicholson, non vedo l’ora di raccontarglielo al mio amico Gigi.
Altri racconti di Giulio Ghirelli
Racconti & Ricordi*anzianiincasa_2019