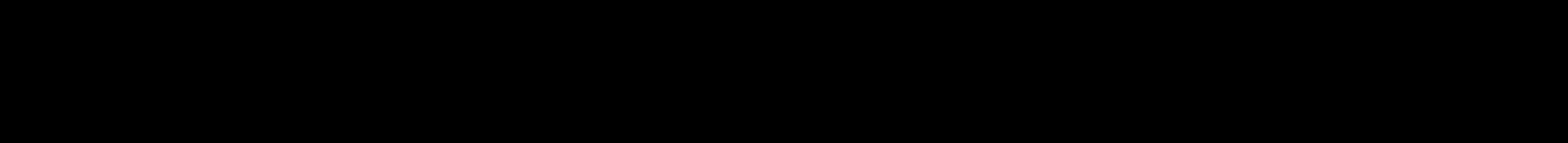
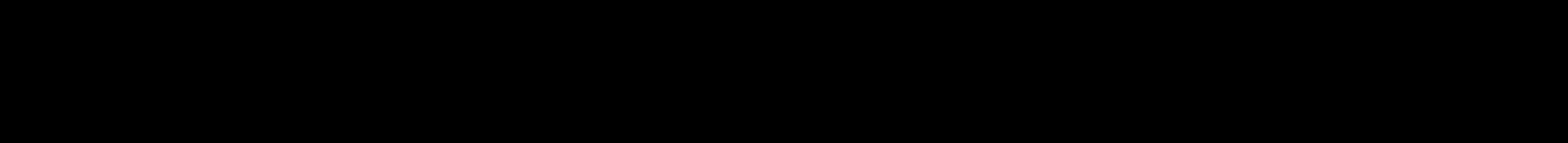
di Sergio Scuffi
 Il granoturco era intensamente coltivato fino al dopoguerra e forniva la farina per polenta, il pasto principale, quasi unico, nei nostri paesi. Si arrivava, addirittura, a consumarla tre volte al giorno, da cui il detto: dešdòtt pulènt e pö l’ induméniga, diciotto polente e poi arriva la domenica (occasione, finalmente, per cambiare menü!).
Il granoturco era intensamente coltivato fino al dopoguerra e forniva la farina per polenta, il pasto principale, quasi unico, nei nostri paesi. Si arrivava, addirittura, a consumarla tre volte al giorno, da cui il detto: dešdòtt pulènt e pö l’ induméniga, diciotto polente e poi arriva la domenica (occasione, finalmente, per cambiare menü!).
Si cominciava con la preparazione del terreno: concimazione a base di letame, già in autunno; aratura all’inizio di primavera.
Subito dopo l’aratura veniva livellato per bene il terreno, attraverso uno o più passaggi con l’erpice, dopodiché si procedeva alla semina. In vista delle successive lavorazioni, si seminavano i chicchi su delle righe perfettamente allineate e parallele, utilizzando una funicella tesa fra le due estremità del campo e sostenuta da pioli, che fungevano anche da distanziatori.
Da ciascuna estremità un seminatore (meglio dire seminatrice, dato che era una mansione quasi sempre svolta dalle donne), munito di grembiule rovesciato a mo’ di sacca (šcusèda) entro il quale stavano i chicchi da seminare, e di una zappetta, procedeva verso il centro interrando i semi, fino a quando i due si incontravano. Ritornati ciascuno alla propria estremità, riposizionavano le funicelle, e riprendevano a seminare lungo la nuova fila, e così fino al termine.
Quando le piantine raggiungevano l’altezza di pochi centimetri, occorreva procedere alla prima sarchiatura (sciarlè dála prüma), per liberarle dalle erbacce.
L’operazione veniva preceduta e facilitata passando un leggero aratro munito di diversi vomeri, regolabile in larghezza e profondità (cultivéta, sciárla), che smuoveva la terra, strappava le radici ed eliminava una buona parte dell’erba. Seguiva il lavoro manuale con una zappa e… le mani per togliere pazientemente l’erba fino all’ultimo filo, con immaginabili dolori di schiena,
conseguenza di giornate intere di lavoro. La sarchiatura veniva ripetuta una seconda volta, durante la quale si procedeva anche al diradamento delle piantine, o trapianto ove vi fossero spazi vuoti (binè, sciarlè dála segónda).
Le piante venivano lasciate a se stesse fino a settembre-ottobre, quando si procedeva a liberarle dalle foglie secche, tagliando anche la parte del fusto (magliásc) al di sopra della pannocchia: questo fogliame, denominato maéra, serviva come alimento delle mucche. Raggiunta la maturazione, tra fine ottobre e l’inizio di novembre, si procedeva finalmente al raccolto delle pannocchie, caricate sui carri e condotte presso le abitazioni.
Qui si procedeva alla loro lavorazione, che consisteva nel liberarle dall’attaccatura che le aveva unite al culmo (dešcucugè), per trasportarle in casa dove, nelle serate autunnali, si sarebbe proceduto a liberarle dalle brattée più esterne (šfuiè).
 La sera, in cucina, tutta la famiglia si metteva in tondo e si occupava della “sfogliatura”. Spesso erano presenti i vicini (fè a idáss: lavorare, a turno, in casa di uno o dell’altro):
La sera, in cucina, tutta la famiglia si metteva in tondo e si occupava della “sfogliatura”. Spesso erano presenti i vicini (fè a idáss: lavorare, a turno, in casa di uno o dell’altro):
occasione per raccontare storie, proporre indovinelli, cantare in coro, cuocere qualche pentola di castagne (farü)
Quando, in un angolo, si accumulava una certa quantità di pannocchie, qualcuno provvedeva a legare dei mazzi con un salescíin, legaccio ricavato da rametti di salice: poi era compito dei ragazzi, man mano, trasportarli verso la lÓbia, ballatoio in legno al quale sarebbero stati appesi, la mattina successiva, per rimanervi qualche mese ad essiccare.
Giunti a gennaio-febbraio, le pannocchie si erano essiccate al punto giusto, per cui venivano ritirate e si poteva procedere alla sgranatura (fè sgiÓ i furmentόon) per liberare i chicchi di granoturco che, insaccati, si portavano per la macinazione al mulino (allora erano numerosi, presenti nelle varie frazioni, ed immancabilmente azionati dalla forza dell’acqua derivata, attraverso canali secolari, dai torrenti che scorrevano nelle adiacenze degli abitati.
 Si ritirava il prodotto finale, contenuto in sacchi distinti per la farina e la crusca, destinata al bestiame. Nell’occasione si portavano spesso al mulino anche le castagne per ottenere la farina de farciámm, oppure il grano (furmènt) da cui si ricavava la farina bianca.
Si ritirava il prodotto finale, contenuto in sacchi distinti per la farina e la crusca, destinata al bestiame. Nell’occasione si portavano spesso al mulino anche le castagne per ottenere la farina de farciámm, oppure il grano (furmènt) da cui si ricavava la farina bianca.
 Immagini estrapolate dal libro
Immagini estrapolate dal libro
Nü’n cuštümáva
su gentile concessione dell’autore
IDVV- ISTITUTO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA VALTELLINESE E VALCHIAVENNASCA
Altri racconti di Sergio Scuffi
Racconti & Ricordi /anzianiincasa_2020