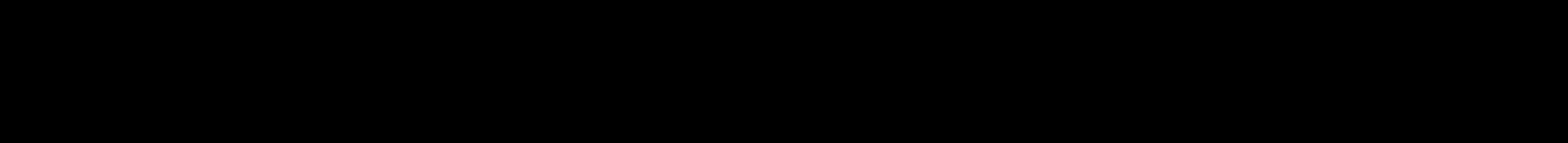
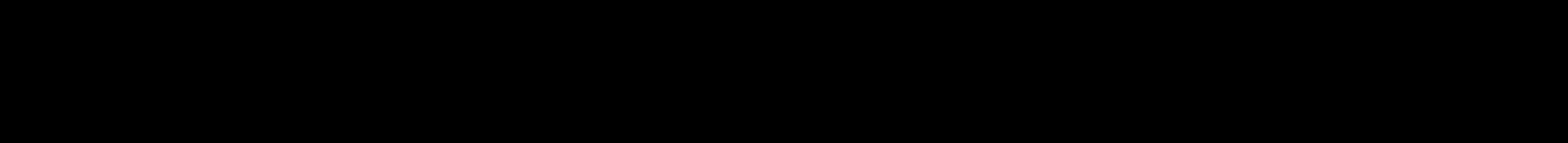
di Giulio Ghirelli
Milano con gli occhi sulle scarpe
Io sono della classe ’44. I miei genitori, giovani di belle speranze, e poco propensi a passare la vita con la schiena piegata sui campi, poco prima della guerra lasciarono la campagna ferrarese e vennero a Milano a cercar fortuna. Mio papà si arruolò nell’Arma dei Carabinieri, e mia mamma trovò lavoro da operaia all’Alfa Romeo – Officina motori aerei.
 Sono nato in una casa di ringhiera di via Piero della Francesca, in un quartiere che nel dopoguerra veniva chiamato riòn dei scigollàtt (rione dei cipollai) per via dei tanti campetti coltivati a ortaggi. Anche se il mangiare non ci è mai mancato, non erano tempi di vacche grasse. A quei tempi non sarebbe servita la raccolta differenziata dei rifiuti, perché c’era ben poco da buttar via. Si riciclava tutto, e non per ecologia. Il gabinetto era in comune sul pianerottolo (solo la latrina) e in casa non c’era l’acqua calda. Il bagno si faceva una volta alla settimana, in una tinozza davanti a una stufetta alimentata con mattonelle fatte con carta messa a macerare nell’acqua, che venivano poi pressate e fatte asciugare per qualche giorno. E i pezzi di legna si recuperavano tra le macerie delle case bombardate.
Sono nato in una casa di ringhiera di via Piero della Francesca, in un quartiere che nel dopoguerra veniva chiamato riòn dei scigollàtt (rione dei cipollai) per via dei tanti campetti coltivati a ortaggi. Anche se il mangiare non ci è mai mancato, non erano tempi di vacche grasse. A quei tempi non sarebbe servita la raccolta differenziata dei rifiuti, perché c’era ben poco da buttar via. Si riciclava tutto, e non per ecologia. Il gabinetto era in comune sul pianerottolo (solo la latrina) e in casa non c’era l’acqua calda. Il bagno si faceva una volta alla settimana, in una tinozza davanti a una stufetta alimentata con mattonelle fatte con carta messa a macerare nell’acqua, che venivano poi pressate e fatte asciugare per qualche giorno. E i pezzi di legna si recuperavano tra le macerie delle case bombardate.
Il cortile era il centro della socialità del caseggiato e le donne chiacchieravano da una ringhiera all’altra intanto che stendevano le lenzuola. Mia mamma aveva la passione del canto e una bella voce, e faceva le pulizie cantando i motivi di allora; sapeva tutte le canzoni di Nilla Pizzi, Luciano Tajoli, Claudio Villa… Così le ho imparate pure io; volete sentire una strofa di Borgo antico di Claudio Villa? “Borgo antico, dai tetti grigi sotto un cielo opaco, io ti invoco, ma per le strade tue si perde l’eco…”
In primavera arrivavano i matarassee, che riempivano il cortile di banchi e attrezzi per cardare e trapuntare i materassi di tutto il caseggiato. Qualche folata di vento marzolino faceva svolazzare i ciuffetti di lanugine, che noi bambini cercavamo di acchiappare, gridando gioiosamente: “Nevica, nevica!”. Alla sera, dal cortile saliva il profumo del minestrone cucinato dalla sciura Colomba, la portinaia. Lei e suo marito che faceva il bigliettaio sul tram sembravano due personaggi usciti da un quadro di Botero: piccoli, tondi e rubizzi. Mangiavano sempre minestrone, e io, nella mia ingenuità, mi chiedevo se quell’alimento producesse così tanto sangue, dato che nella guardiola della portineria era appesa in bella mostra una cornice con dentro un attestato dell’AVIS con tanto di medaglia d’oro.
A quei tempi, invece del frigorifero, avevamo la giazzèra, un mobiletto di legno foderato di zinco con dentro il ghiaccio. Quando entrava in cortile il carretto che trasportava il ghiaccio, noi bimbi allungavamo golosamente le mani per raccogliere qualche scaglia, e quello era il nostro gelato. Non avevamo Kinder e Nutella, ed eravamo felici se potevamo avere due Lirette per comprare dall’ambulante una carruba o una bustina di farina di castagne.
Al giovedì sera si andava con le sedie a casa della sciura Esperia, l’unica ad avere la TV sul nostro pianerottolo, a vedere “Lascia o raddoppia?” E il venerdì era festa grande, perché la mamma comprava dal polentatt il merluzzo fritto e una fettona di polenta. La TV l’avevano in pochi, ma in quasi tutte le case c’era la macchina da cucire, e la mamma, nelle ore libere dal lavoro, stava a rammendare e cucire stoffe di ogni genere per il nostro vestiario. Le scarpe erano un bene di valore, da tenere da conto.
Io avevo un paio di scarpe che servivano per tutte le stagioni, e un paio di sandali per l’estate. Le scarpe venivano rimpiazzate solo quando, dopo aver fatto la spola infinite volte nella bottega del ciabattino, erano irrimediabilmente consunte.
A quei tempi, era in auge un accessorio per consumare meno le suole: il ciabattino inchiodava (su punta e tacco delle suole) delle mezzelune di metallo, una sorta di mini ferro di cavallo. Erano in molti ad essere “ferrati” in questo modo. Con queste ferrature camminavi facendo: tip-tap, tip-tap… come Fred Astaire!
A proposito, mi viene in mente un vecchio scioglilingua milanese da dire svelto: “Tì che te tàchet i tac, tàcum i tac. Mi tacàt i tò tac a tì? Tàcheti tì i tò tac”! Ma anche con le mezzelune, quanto potevano durare le scarpe a un bambino vivace che passava i pomeriggi ai giardini di corso Sempione con una banda di ragazzini scatenati? Mio padre, pover’uomo, era disperato. Non si poteva scialare troppo, ma cosa poteva fare? Mandarmi in giro a piedi scalzi? Allora, quando arrivava il triste momento, papà mi portava a piedi fino a Porta Venezia, dove c’era un magazzino di scarpe all’ingrosso.
La scelta delle scarpe, papà la faceva con un’unica priorità: che fossero il più possibile robuste ed economiche. E a me poco importava cosa mi ritrovavo ai piedi, l’importante era che potessi tirarci dei bei calci al pallone, o arrampicarmi tra le macerie delle case bombardate. Poi un bel giorno, nel magazzino delle scarpe, dissi a papà: “Voglio queste”. Erano un paio di leggeri mocassini blu, molto simili a quelli che portava Giorgio, un ragazzo più grande di me di un paio d’anni, figlio del padrone di casa. Era già da un po’ di tempo che “filavo” le scarpe di Giorgio. Lui non faceva parte della nostra banda, non si mischiava coi ragazzi di strada. I suoi genitori lo tenevano in una campana di vetro.
Le uniche uscite che faceva erano per andare a scuola, per andare in piscina o a giocare a tennis. Sempre sulla Fiat Topolino di suo padre, e sempre con quegli eleganti mocassini blu.
“Ma sono scarpe delicate, ti durano poco” presagì mio padre, dopo che il commesso gli aveva comunicato il prezzo. “Voooglio queeeste!”. Il papà, che aveva un cuore molto più grande del suo portafoglio, mi accontentò.
Avevo dodici anni ed era la prima volta che potevo scegliere qualcosa. Poi, un paio di mesi dopo, come premio per essere stato promosso, ottenni il mio primo paio di blue-jeans. Fu la prima estate che passai senza sandali e calzoncini corti, ed ero molto contento.
Camminavo per la strada con gli occhi sulle scarpe, e sui jeans che vi cadevano sopra.
E avevo la certezza di essere diventato grande.
Altri racconti di Giulio Ghirelli
Racconti & Ricordi*anzianiincasa_2019